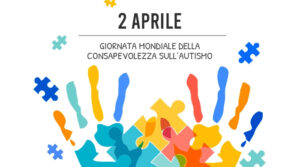Carletto Romeo
Filosofare sulla guerra è di nuovo “Trendy”

Lo Spunto Letterario
di Gaetano Riggio
Filosofare sulla guerra è di nuovo “Trendy”
Ciò di cui non si può parlare, è tabù: un reale divenuto socialmente scabroso, che si può fingere che non esista nella misura in cui, non parlandone, esce dall’orizzonte simbolico del linguaggio e di conseguenza del pensiero, in cui soltanto le cose vengono all’essere dal punto di vista umano.
La reazione isterica, individuale o collettiva, quando qualche temerario viola un tabù, funziona allora come una misura di quante precarie siano le difese da quel reale negato, quando le vicissitudini mutevoli della storia urgono, e lo spingono a riemergere, a imporsi imperiosamente come un dato ineliminabile della condizione umana.
C’è allora da chiedersi, ad esempio, se l’articolo 11 della nostra Costituzione – che solennemente proclama che “l’Italia ripudia la guerra” -, non sia niente altro che una delle tante formulazioni ufficiali di quel tabù della guerra, che si è ufficialmente istituzionalizzato dopo la Seconda Guerra Mondiale, alla fine del Trentennio tra la Prima Guerra Mondiale e la Seconda, che ha provocato circa 100 milioni di morti.
Quanto obsolete e truculente risuonavano, alle nostre orecchie di studenti delle scuole superiori, negli anni Ottanta, la prosa dannunziana dei celeberrimi romanzi in cui egli esalta l’ideale superomistico del guerriero, o quella dei giovani futuristi quali Marinetti e Papini, che dalle colonne dei giornali glorificavano la guerra imminente:
“3. La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi ed il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno.
- Non v’è più bellezza, se non nella lotta.
- Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del mondo – il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna.”
Si tratta di passi tratti dal “Manifesto del futurismo” (1909), di Filippo Tommaso Marinetti, che ai più perspicaci tra noi parevano l’effetto di menti invasate, e di giovani energumeni affetti da patologia mentale.
Non poteva essere altrimenti, per noi, che eravamo cresciuti sotto l’influenza della cultura giovanile del Sessantotto, che gridava slogan del tipo “fate l’amore, non la guerra”, “mettete dei fiori nei vostri cannoni” (I Giganti, 1967), oppure intonava i versi irenici di John Lennon “Imagine all the people / living life in peace” (“Imagine”, 1971).
Certo, erano gli anni della contestazione violenta, che sfociò in alcune minoranze nel fenomeno della lotta armata. Ma quegli slogan erano in evidente sintonia con lo spirito della nostra Costituzione che “ripudia la guerra”, e di altre Carte dei diritti, nazionali e sovranazionali, in primo luogo lo “Statuto delle Nazioni Unite” (giugno 1945), che istituiva un’organizzazione sovranazionale (ONU) finalizzata
“a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità […] a praticare la tolleranza e a vivere in pace […] ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ad assicurare, mediante l’accettazione di principi e l’istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell’interesse comune […].”
Ho citato il preambolo dello Statuto, che proprio nel suo articolo 1 proclama la pace come valore supremo e il suo mantenimento come fine precipuo dell’organizzazione:
“Mantenere la pace, […] prevenire e rimuovere le minacce alla pace e […] reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace […] conseguire con mezzi pacifici […] la soluzione delle controversie […] che potrebbero portare ad una violazione della pace”.
Insomma la parola “pace” era divenuta un mantra, che era obbligo recitare o formulare, tanto più apotropaica quanto più incombevano le incognite minacciose della guerra fredda e dell’olocausto nucleare.
Per non parlare poi delle ricadute pedagogiche ed educative della preminenza di questo valore: “educare alla pace”, “educare al rispetto e alla cooperazione”, e così via. Il momento più alto, in Italia, di questa affermazione dell’ideologia pacifista, è l’approvazione del diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare, da parte del Parlamento, nel 1972, con la legge che istituisce il servizio civile obbligatorio per chi rifiuta di prestare il servizio militare, ed infine la sospensione dello stesso obbligo del servizio militare nel 2004.
Un’esenzione comunque non del tutto coerente con l’articolo 52 della stessa Costituzione, che afferma che “La difesa della patria è sacro dovere del cittadino”. Il che ci induce a considerare che il reale della guerra, benché rimosso, ritorna sintomaticamente come possibilità di un inquadramento civico e militaresco del cittadino, chiamato al sacro dovere della difesa della Patria.
L’ideale del pacifismo, indubbiamente nobile, si è fatto poi ibridare da altri valori (meno nobili) tipici dell’edonismo consumista del capitalismo di matrice occidentale, che hanno avuto il loro pieno trionfo con la svolta neoliberale degli anni Ottanta, con R. Reagan e M. Thatcher, che hanno elevato l’individualismo e il culto del sé, sconnesso da ogni legame, a cifre dell’Occidente, e delle sue cosiddette democrazie liberali.
Il risultato è stato il seguente: un individuo autoreferenziale, che non concepisce altro sacrificio che non sia autosacrificio: un impegno che non sia gratificazione del sé, da raggiungere attraverso il successo e lo sforzo della massima prestazione nel lavoro.
La guerra è allora diventata assoluto disvalore non solo in quanto violazione della dignità della persona, che non può mai essere ridotta a mezzo, ma anche in quanto negazione di quel sé autocentrato che interpreta lo spendersi per gli altri e per la comunità come una lesione inaccettabile della sua integrità narcisistica.
Eppure il tabù è caduto: i temerari hanno sfidato il divieto, e il reale orribile della guerra viene ora evocato come un possibile con cui fare i conti: sarebbe ora, secondo costoro, di togliere la testa dalla sabbia, e di educare i giovani a saperlo affrontare non arretrando per viltà (come in realtà perlopiù accadrebbe, al giorno d’oggi), ma avanzando con rinnovato spirito di abnegazione e sacrificio per il bene superiore della comunità nazionale e dello Stato, e la difesa dell’UE e dei suoi valori!
Ecco quindi tornare in voga i Papini, i Marinetti, che a noi studenti degli anni Ottanta parevano delle bizzarrie di un passato ormai irreversibile, anche se questi odierni e improvvisati elogiatori dello spirito guerriero sostengono che si tratta soltanto di fare di necessità virtù, e di realizzare che il mondo sociale delle comunità statuali umane è in ultima analisi il regno della forza, ove soltanto chi sa usarla collettivamente come extrema ratio può difendere l’ordine civile della società da un’improvvisa irruzione della violenza esterna usurpatrice e del caos.
Ecco allora, qualche giorno fa, un intellettuale come Umberto Galimberti o il meno noto Antonio Scurati di “Repubblica”, rispolverare argomentazioni antiche quanto la guerra stessa:
“la pace (che pure è una bella cosa della civiltà) rende l’uomo imbelle, intorpidisce l’animo!”, afferma Galimberti intervistato da Augias, che annuisce;
“Dove sono ormai i guerrieri d’Europa?”, lamenta Antonio Scurati dalle colonne di “Repubblica”: “per fare la guerra non bastano le armi, ci vogliono uomini e donne disponibili a uccidere e farsi uccidere!”
In linea di principio il ragionamento è valido: occorre sapersi difendere, e stare all’erta contro eventuali nemici, così come è vero che la pace intorpidisce, e rende l’uomo imbelle. Analogamente, l’ozio lo rende pigro, e poco idoneo alla fatica e alla sopportazione del dolore. Ma se dall’astratto scendiamo al concreto, anche una verità può rivelarsi essere un sofisma.
In generale, stiamo assistendo a un cambiamento di paradigma: da uno che presupponeva come possibile il superamento della guerra – da non considerare più come una legge di natura che esige che la vita sia una guerra di tutti contro tutti (“bellum omnium contra omnes”) -, allo scopo di realizzare la coesistenza pacifica tra le società umane in strutture sovranazionali (sul modello della “Pace perpetua”, elaborato dal filosofo I. Kant nel 1795), a un altro paradigma regressivo, che prende di nuovo atto che la legge darwiniana della lotta per l’esistenza, in un habitat limitato negli spazi e nelle risorse, è una condizione ineludibile dei viventi e degli uomini, che richiede che lo spirito antagonistico e il senso di appartenenza al proprio gruppo siano coltivati e valorizzati, onde avere una chance di sopravvivenza, quando il demone della guerra si ridesta, e mette i popoli l’uno contro l’altro.
In questo cambiamento di paradigma, la percezione della minaccia dell’altro si è di nuovo acuita fino al delirio paranoico persecutorio, in cui l’immaginazione del pericolo ha preso il posto del pericolo stesso, e in cui l’egemonia della narrazione pubblica alimenta o incanala in una determinata direzione le angosce e le speranze delle popolazioni.
Quanto di vero e quanto di letteralmente falso vi è dunque nella percezione di una minaccia incombente, che renderebbe urgente la rigenerazione di uno spirito guerriero in un’Europa resa effeminata da troppo Welfare (ben venga allora l’austerità e i tagli alla spesa sociale!), in modo da avere carne da cannone sufficiente, pronta a uccidere e farsi uccidere?
Su questa cruciale questione né Scurati né Galimberti hanno fatto le dovute considerazioni.
Quanto un certo tipo di narrazione può dare corpo a un pericolo immaginario? Quanto nelle società umane il rapporto causa – effetto può essere manipolato e invertito, così che non sia l’allerta innescata da un rischio effettivo a condurre alla guerra, ma la percezione di un’allerta alimentata ad arte a costruire un pericolo immaginario, un nemico, che poi potrebbe conduce alla guerra?
In altre parole, cui prodest? Chi ha interesse alla guerra, e alla mobilitazione economica e sociale di un clima da guerra imminente, anche se poi non verrà combattuta?
Guardiamo una carta geopolitica dell’Europa e dei suoi confini. Da dove potrebbero provenire i pericoli se non dal Mediterraneo sudorientale, da un’area destabilizzata criminalmente dalla Nato negli ultimi decenni?
Interi Stati non esistono più a causa delle guerre umanitarie della NATO, e dello Stato neocoloniale (nonché razzista e genocida) di Israele: Libia, Libano, Siria, Iraq, Gaza, Cisgiordania, regioni curde, alawite, e di altre minoranze etniche e religiose.
Eppure ci si arma, e si invoca una nuova generazione di guerrieri, per difendersi dell’espansionismo russo, una minaccia ridicola sulla cui confutazione evitiamo di tornare ancora una volta. C’è puzza di imbroglio!
In effetti la paura della guerra è spesso sfruttata dagli Stati per obiettivi impropri, che non sono la difesa del territorio dai nemici esterni.
Si sfrutta spesso uno stato emergenziale fittizio per mantenere il potere deviando la rabbia e la frustrazione dei cittadini dai governanti ai presunti nemici esterni.
La Russia “deve” rimanere il nemico, perché altrimenti l’élite corrotta e fallimentare dell’UE, caduto il velo della propaganda e delle menzogne somministrate finora all’opinione pubblica, potrebbe essere travolta dal malcontento e dallo scandalo. Dunque lo spettacolo deve continuare, e cambiare registro non è possibile.
In aggiunta, l’oligarchia che ci comanda potrebbe avere bisogno di un’economia di guerra per fare profitto e speculazione finanziaria nel settore industriale e militare, e giustificare così i tagli alla spesa pubblica nei settori del Welfare.
Soprattutto in questa fase di crisi, e deindustrializzazione dell’Europa, la guerra paventata potrebbe alimentare una crescita esponenziale della domanda statale di armamenti, e quindi favorire una conversione alla produzione bellica dei settori economici in crisi. Ovviamente, il tutto avverrebbe spremendo i cittadini, perché gli Stati comprano le armi con le tasse e il debito pubblico, pagati dai cittadini, mentre il complesso industriale e finanziario realizza profitti enormi.
In effetti, se leggiamo le analisi più attente e ci mettiamo anche del buon senso, di accorgiamo che gli indizi portano nella direzione ipotizzata.
Tutta questa mobilitazione della piazza, da parte degli europeisti, pare più che altro una miserabile farsa in cui tanti ingenui vi partecipano convinti che sì: l’Europa è in pericolo, e ha bisogno di giovani guerrieri, pronti a uccidere e a farsi uccidere in guerra!
Gaetano Riggio
Segui gli altri “Spunti Letterari” di Gaetano Riggio qui:
https://www.carlettoromeo.com/category/lo-spunto-letterario/
carlettoromeo.com è un blog multimediale senza alcuna sovvenzione pubblica…
Se ti piace quello che facciamo, condividi i nostri articoli sui social…
Se vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi farlo con una libera donazione Paypal
GRAZIE